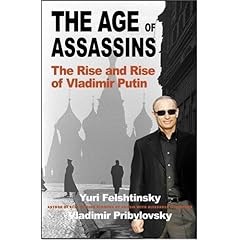, che ha ripubblicato in traduzione italiana un articolo-inchiesta del giornalista britannico Johann Hari sugli “schiavi-bambini nel XXI secolo.” L’articolo è apparso nella
del 15 marzo scorso. Il resoconto di Hari è doloroso e impressionante. Ovviamente il plauso più sentito va a lui.
Questa è la storia della tratta degli schiavi-bambini nel XXI secolo. Il mio viaggio nel mondo di questo particolare tipo di malavita ha avuto inizio dove più numerosi sono i bordelli e le prostitute: in Asia, dove stando alle stime delle Nazioni Unite ogni giorno un milione di bambini viene venduto e comprato.
Il viaggio mi ha portato in luoghi che non pensavo potessero ancora esistere: una prigione sotterranea in una zona di confine del Bangladesh dove regna la malavita e dove i bambini vengono segregati dietro le sbarre in attesa di essere condotti nei bordelli in India; un postribolo di ferro dove le donne hanno trascorso una intera vita di violenze sessuali; una clinica dove curano bambini di 11 anni malati di sifilide.
Ma la nostra storia comincia come tutte le storie: con una bambina e una bugia. Sufia si avvicina per parlarmi in un centro di recupero per bambini finanziato da «Comic Relief». Sufia finora ha parlato della sua drammatica esperienza solo con le assistenti del centro. Ma vuole che il mondo sappia quanto le è capitato.
Entra nella stanza avvolta nel suo sari rosso con delle grosse borse nere sotto gli occhi, sorprendenti per la sua età. Parla della sua esperienza lentamente, quasi con un filo di voce. Sufia è cresciuta in un villaggio vicino a Khulna, nella regione sud-occidentale del Bangladesh. I suoi genitori erano contadini e lei aveva sette fratelli e sorelle. «I miei genitori non potevano permettersi di badare a me», mi dice. «Non avevamo nemmeno il denaro per comprare da mangiare».
E qui arriva la bugia. Quando Sufia aveva 14 anni, una vicina disse ai suoi genitori che poteva trovarle un buon lavoro a Calcutta come collaboratrice domestica. Avrebbe vissuto bene, avrebbe imparato l’inglese e avrebbe avuto un futuro tranquillo. «Non stavo nella pelle dalla felicità», mi dice Sufia. «Ma appena siamo arrivate a Calcutta ho capito che c’era qualcosa che non andava. Non sapevo cosa era un bordello, ma capivo che la casa dove mi aveva portato era un brutto posto. Le donne indossavano abiti succinti e c’erano uomini dall’aspetto poco rassicurante che entravano ed uscivano». La vicina di casa in cambio di Sufia intascò 50.000 takka, circa 600 euro. Poi le disse di fare ciò che le avrebbe ordinato e scomparve.
A questo punto il lento monologo di Sufia si arresta. Volge lo sguardo dall’altra parte mentre continua a dondolarsi sulla sedia. Poi continua: «non potevo uscire. Dovevo vedere 10 uomini al giorno». Un’altra lunga pausa. «Prima d’allora non sapevo nulla degli uomini. È stata una cosa spaventosa».
Ha visto quanto accadeva in quel posto alle donne più grandi. Vengono costrette a «dare alla luce un figlio». Le loro figlie vengono allevate per fare le prostitute-schiave. Dopo tre mesi due altre ragazze imprigionate in quel postribolo le dissero che avevano un piano per fuggire. Intendevano mettere da parte i sonniferi che venivano distribuiti ogni sera - per impedire loro di singhiozzare, di lamentarsi e di respingere i “clienti” - per poi metterli nelle bevande dei loro carcerieri e così darsela a gambe.
Il piano funzionò. «Non avevo la minima idea di come orientarmi in città, ma loro erano delle ragazze sveglie», dice Sufia. Quando finalmente rivide la casa dei genitori fece un proposito: «non dirò mai alla mia famiglia cosa è accaduto. Dissi ai miei che avevo lavorato come cameriera e che mi erano mancati troppo. Non posso mai parlare con nessuno della mia esperienza, a parte la gente di qui. Se lo facessi nessuno mi sposerebbe e arrecherei disgrazia alla mia famiglia e la mia vita sarebbe distrutta».
Sa che deve sottoporsi al test dell’Hiv. Ha già fissato l’appuntamento due volte, ma non ce la fa. Non vuole sapere.
Sufia è stata venduta a una banda organizzata che commercia in esseri umani in tutti i continenti e che vende carne umana in cambio di denaro. Questa gente continua ad operare - e, a differenza di Sufia, la maggior parte delle donne non riescono a fuggire.
Sul lato di una strada sterrata a Jamalpur, una cittadina del Bangladesh, c’è un cancello di ferro. All’interno un labirinto di fragili baracche con il tetto in lamiera e all’interno di ciascuna baracca una donna in attesa.
Seduta sul letto dentro una delle baracche trovo Beauty, una donna di 34 anni. Quando le dico che vorrei mi parlasse della sua vita, mi sorride perplessa. «Mio cognato mi ha venduto allo sfruttatore quando avevo 13 anni», mi spiega. «Un giorno mi ha portato via e mi ha condotto qui. Al mio arrivo lo sfruttatore mi ha frustato e mi ha detto che non dovevo mai uscire dal bordello. Ero distrutta. Odiavo questo posto. Continuavo a pensare alla mia famiglia, a mia madre e piangevo in continuazione. Ma lo sfruttatore mi frustava continuamente e mi diceva che dovevo lavorare».
Ha avuto uno squarcio di felicità a 19 anni. Uno degli uomini che frequentava regolarmente il bordello le disse che si era innamorato di lei e le chiese di sposarlo. Pagò una somma di denaro per portarla via e ricondurla al suo villaggio natale da sua madre e da sua sorella. Era stato il sogno di Beauty: «pensavo di tornare ad una vita felice e normale». Ma la sua famiglia la respinse. Avevano sentito dire che faceva la prostituta - suo cognato aveva detto a tutti che era stata una sua libera scelta - e così «mia sorella mi tormentava, mi insultava, mi prendeva in giro e la gente del villaggio mi evitava». Dopo un po’ anche suo marito si stancò di lei e la rivendette al bordello. «Smisi di mangiare», mi racconta. «Volevo morire». Ed eccola qui. Sa che non potrà mai avere né un marito né una casa. Il suo destino è quello di essere evitata da tutti.
Fuori del bordello queste donne hanno una sola strada: diventare esse stesse delle sfruttatrici, mettere su un loro bordello e «guadagnarsi» la liberta’. Ma Beauty mi dice che non può farlo: «No, no... odierei essere una “madam”. Sono un cattiva ragazza, ma non fino a quel punto». Si passa le mani tra i capelli e aggiunge: «so che è triste. È la storia della mia vita. Non un granché, vero?».Non è difficile ricostruire le rotte dei trafficanti. Il confine tra India e Bangladesh è un lungo fiume dalle acque increspate. Mentre me ne sto in prossimità del confine posso vedere davanti a me la più popolosa democrazia del mondo, mentre alle mie spalle ci sono prigioni con le sbarre di ferro dove vengono tenute le ragazze del Bangladesh prima di essere vendute in India.
Tutta la gente del luogo lo chiama apertamente il «luogo dei trafficanti». Non si nascondono nemmeno. È inutile chiamare la polizia, mi ripetono gli abitanti del villaggio, perché i poliziotti sono sul libro paga dei trafficanti. Mi reco alla più vicina stazione di polizia - un bellissimo edificio di marmo bianco circondato da lussureggianti aiuole molto ben curate - per fare qualche domanda.Il vice-ispettore, un ufficiale sulla trentina in divisa marrone e un sorriso tranquillo, mi fa segno di “no” agitando al mano. «Non ho commenti da fare su questa faccenda», mi dice. Che vuol dire che non ha commenti da fare? Sicuramente la mia non è una domanda difficile. «Non ho intenzione di parlarne», e questa volta il suo tono di voce è più deciso.
Vi meravigliate allora se tutta le gente della vostra comunità pensa che prendiate le bustarelle? L’ufficiale di polizia accusa il colpo. «Hanno un problema di atteggiamento. Sono poveri e se la prendono con chiunque per i loro problemi», e scoppia a ridere.
Dacca, la capitale del Bangladesh, è una città assordante, rumorosa, caotica che mette a dura prova la vista l’udito, tutti i sensi. In questa megalopoli di 14 milioni di abitanti stipati come sardine, basta gettare lo sguardo in una qualunque strada affollata per essere bersagliati da più stimoli sensoriali di quanti in genere ce ne arrivano in una settimana.
Vistose auto occidentali sono bloccate nel traffico accanto a veicoli scassati e arrugginiti. Povere, eteree vagabonde si aggirano tra le automobili con i figli in braccio e la mano tesa per chiedere l’elemosina. Gli operai camminano tenendo in equilibrio sulla testa carichi enormi. Bambini sono impegnati a lavorare con la macchina da cucire sui tetti delle case. Donne pesantemente truccate ti chiedono 10 takka per farti vedere il serpente danzante nascosto nella scatola di legno che portano legata al collo. Uomini aggrappati agli autobus urlano ai padroni dei risciò che urlano ai pedoni che urlano parlando al cellulare.
Tutto questo accade accompagnato da un assordante rumore di fondo, una sorta di “melodia di Dacca”: lo strombazzare dei clacson delle auto, il cigolio dei risciò, le campanelle e le continue urla della gente.
In mezzo a questo tremendo caos ci sono 300.000 bambini di strada che vivono (e muoiono) per conto loro. Dormono a piccoli gruppi nella zona portuale, intorno alla stazione degli autobus o negli edifici in costruzione sparsi in tutta la città. Sono il sogno dei trafficanti, prede senza difesa.Seduto sul ponte in prossimità del porto trovo Mohammed e la sua piccola banda di amici. Ha 14 anni, indossa una sudicia camicia di cotone dozzinale e ha la zazzera incolta. Dimostra 10 anni tanto il suo corpo è scarno e scheletrico. Sulla caviglia ha un adesivo della serie Pokemon e lui e i suoi amici accettano di farmi vagabondare insieme a loro per tutta la giornata.
Mohammed sta insieme agli altri bambini da quando è fuggito a Dacca nella speranza di ritrovare sua madre che era stata costretta a lasciare i figli con la matrigna per andare a lavorare e mandare i soldi a casa.
Trascorrono le ore del giorno vagando per le strade di Dacca, raccogliendo pezzi di carta straccia e mettendoli in un sacco. Se la raccolta va bene, alla fine della giornata possono rivendere la carta per 10 takka - circa 15 centesimi di euro sufficienti a comprare un pasto e qualche spliff (NdT, canna con il tabacco).
Si lavano nelle acque fetide e puzzolenti del fiume e forse per questo Mohammed non fa che grattarsi il braccio infettato dalla scabbia. Qualche volta riescono a risparmiare qualche spicciolo per vedere un film - i suoi preferiti, mi dice, sono i film d’azione hollywoodiani e i film musicali di Bollywood.
Tutte le sere si mettono fuori dei ristoranti per rimediare qualche avanzo - e poi cercano di rubare qualcosa al mercato ortofrutticolo. Mi portano lì a mezzanotte, nell’unico luogo illuminato di una città avvolta dalle tenebre. Il mercato ortofrutticolo è un’ enorme città brulicante di persone dove migliaia di venditori eseguono una sorta di danza gli uni intorno agli altri trasportando sulla testa in apposite ceste montagne di patate e oceani di cavoli e mercanteggiando con i dettaglianti e con i proprietari di ristoranti. Mentre seguo la banda di ragazzini che rubacchia qualche frutto sono attratto dall’odore del peperoncino rosso e degli agrumi.
Poi finalmente, alle tre del mattino, si adagiano in un angolino vicino al porto e si preparano a dormire. I sacchi che usano per raccogliere la carta diventano rudimentali sacchi a pelo e si stringono gli uni agli altri per proteggersi dal freddo. Nel porto ci sono migliaia di bambini e famiglie che passano la notte all’addiaccio.
I ragazzini fumano uno spliff e ingoiano qualche sonnifero che hanno comprato. «Se siamo fatti non proviamo troppo dolore se arrivano i poliziotti e ci bastonano», mi spiegano. «So di aver rovinato la mia vita», aggiunge Mohammed. «So di essere un ragazzaccio e so che non uscirò mai di qui. Non ho speranze, non ho futuro. Cosa pensi che dovrei fare?». E d’improvviso mi rendo conto che la sua non è una domanda retorica. Mi sta sinceramente chiedendo consiglio.
La paura dei trafficanti di carne umana aleggia sulla testa di questi bambini come una minacciosa nuvola carica di pioggia. Il solo momento in cui Mohammed tradisce le sue emozioni è quando ricorda una ragazzina di nome Muni che era sua amica.
Un giorno di giugno dell’anno scorso, quando aveva nove anni e mezzo, un vecchio l’ha avvicinata e le ha detto che se l’avesse seguito le avrebbe trovato un buon lavoro. La piccola ha rifiutato ben sapendo cosa accadeva ai bambini quando andavano con queste persone. Ma lui l’ha portata via con la forza. Gli altri ragazzini hanno tentato di dirlo alla polizia, ma i poliziotti li hanno cacciati via.Il corpo della piccola è stato trovato tre giorni dopo: era stata violentata e strangolata. Mohammed è convinto che l’hanno uccisa perché si è rifiutata di farsi ingannare dalle bugie dei trafficanti e di farsi portare in un bordello e si è difesa con tutte le sue forze.
Mohammed ha bisogno di dormire. Si deve svegliare tra quattro ore per cominciare a raccogliere la carta straccia. Uno dei ragazzi deve rimanere di guardia - «ma è difficile», dice. Gli chiedo cosa gli piacerebbe avere da grande pensando che mi risponderà come fanno di solito i bambini che sognano di avere un macchinone lussuoso. «Avere?», mi chiede. «Vorrei avere mia madre». E ciò detto sorride amaramente e chiude gli occhi.
C’è un piccolo gruppo di cittadini del Bangladesh che ha visto rapire i propri figli dai mercanti di carne umana e che ha deciso - come Muni, con i suoi piccoli pugni - di difendersi e di reagire. Sono finanziati da Sport Relief e dipendono dalle donazioni in denaro dei cittadini britannici.Ishtiaque Ahmed è un intellettuale che - snocciolando una interminabile serie di numeri e statistiche - mi racconta come ha creato «Aparajeyo» (Imbattuti). È una delle principali organizzazioni che nel Bangladesh lottano contro la tratta dei bambini e delle bambine da avviare nei bordelli. Organizzano scuole nelle strade e offrono un rifugio ai bambini che sono stati fatti oggetto di violenze ed inoltre pagano un esercito di bambini recuperati dalla prostituzione che vanno in giro per la città ad insegnare agli altri bambini come difendersi dai trafficanti. Combattono la schiavitù salvando un bimbo per volta.
Faccio la loro conoscenza all’ultimo piano di un grattacielo trasformato in casa di accoglienza per bambini e bambine violentati che sono riusciti a fuggire. Sembra un posto come tanti altri con numerosi bambini che giocano e strillano. Per un momento non sono prede, sono solo bambini.Una ragazza piuttosto alta con gli zigomi sporgenti sta cantando. Mi stringe la mano e dice di chiamarsi Shelaka e di avere 16 anni. Poi, scegliendo con cura la parole e senza alcuna timidezza mi racconta come è finita qui.
È cresciuta in un villaggio a tre ore da Dacca e ha sempre amato cantare. «Cantare è la sensazione più bella del mondo», mi dice. Ma arrivata alla pubertà i suoi religiosissimi genitori le dissero che non stava bene che una ragazza musulmana cantasse e che non doveva più pensare a questi «stupidi sogni».
«Se mi mettevo a cantare mi picchiavano», mi racconta. E così decise di fuggire in città per poter continuare a cantare. Vendette la sola cosa che possedeva - l’orecchino ornamentale al naso - e comprò un biglietto dell’autobus diretto a Dacca. Arrivata in città chiese dove era la scuola di canto. Si aggirò per le strade e quando si fece notte una venditrice ambulante di dolciumi le disse che poteva dormire a casa sua. Shelaka la seguì perché la venditrice ambulante le era sembrata una persona gentile. Ma una volta arrivati a casa della signora, si presentò il padrone di casa con alcuni delinquenti. Shelaka fu sequestrata e tenuta prigioniera per tre mesi e costretta ogni giorno a prostituirsi fin quando la venditrice ambulante la aiutò a fuggire. Vagando per le strade capitò per caso dinanzi ad una delle scuole dell’organizzazione «Aparajeyo» e lì fu accolta ed ospitata.Vive qui da tre anni e continua ad essere aiutata e seguita. Le piace molto. «Sono come una bella famiglia». È iscritta all’Accademia del Bangladesh dove studia canto. Mi chiede se può cantare per me e la sua voce - pur in mezzo ad un frastuono di clacson e di campanelle dei risciò - è calma, bella e pura.
Una delle più belle realizzazioni di «Aparajeyo» si trova nelle enormi e degradate periferie di Khalijpur. In una minuscola stanzetta umida fatta di fango e di lamiera, trovo Rehana, una donna di 33 anni con la fronte piena di rughe. Mi racconta di come suo fratello ha venduto suo figlio per 3.000 takka - poco più di 30 euro. Rehana sapeva da anni che suo fratello era un mercante di bambini. «Mi vergognavo», dice. «Trafficava in bambini perché era povero, ma questo non lo giustifica».
«Andare alla polizia era inutile», mi dice. «I poliziotti erano tutti corrotti». Ma poi nel 2005, proprio il giorno della festa di Eid, suo marito litigò con suo fratello. Due giorni dopo suo fratello andò a prendere suo figlio di sei anni, Shamsul, alla moschea e lo vendette. Non contento di questo derise suo cognato dicendogli che suo figlio si trovava ormai in un bordello in India. «Sono impazzita, sono impazzita», mi racconta. «L’ho cercato dappertutto. Ho passato tutta la giornata a girare per le strade chiamandolo per nome. Non riuscivo a credere a quanto mi stava succedendo».
Dopo due anni di disperazione, Rehana vide un annuncio su un giornale. L’annuncio era stato messo da «Aparajeyo» e diceva: conoscete questo bambino? «Era Shamsul», mi dice commossa. La polizia l’aveva trovato che vagava per le strade e lo aveva affidato all’istituto. Non conosceva né il suo nome né l’indirizzo di casa.
«Quando l’ho riabbracciato era magrissimo e piangeva di continuo», mi dice la madre. «Se non mi vedeva accanto a lui si metteva subito a piangere. Faceva delle cose stranissime: fissava il sole fino al tramonto. Ma il fatto di averlo potuto ritrovare è stato meraviglioso».Shamsul si aggira per la casa mentre il sole tramonta alle sue spalle. Lo zio che lo ha venduto è sparito. Rehana è convinta che gestisca un traffico di bambini da qualche altra parte. «I trafficanti non abbandonano mai il loro mestiere», mi dice. «Io ringrazio Dio ogni giorno per il fatto che ci sono persone come quelli di “Aparajeyo” che lavorano per fermarli».
Suo figlio si siede sulle sue ginocchia. Almeno un bambino sottratto ad una vita di violenze sessuali. Passa la mano tra i capelli della mamma e con l’altra mi allunga una pallina viola e sorride.
© The Independent. Traduzione di Carlo Antonio Biscotto